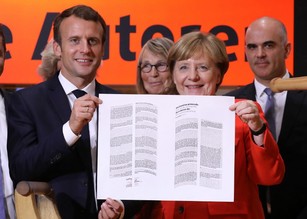La genesi della Dichiarazione universale dei diritti umani che oggi compie 70 anni. Al centro l'individuo umano e i suoi diritti sociali, politici, spirituali e materiali
La parola chiave è "individuo", inteso come essere umano titolare di diritti che nessuna forma sociale o di potere può coartare, limitare o cancellare. Questo, sostanzialmente, è il contenuto della Dichiarazione universale dei diritti umani approvata a Parigi il 10 dicembre del 1948 dall'Assemblea delle Nazioni Unite allora formata da 58 membri (non c'erano, ad esempio Germania, Italia e Giappone, Paesi sconfitti nella Seconda Guerra Mondiale che sarebbero entrati anni dopo) e tante piccole nazioni che si sarebbero aggiunte col tempo all'Onu. Otto Paesi (Arabia Saudita, Bielorussia, Cecoslovacchia, Jugoslavia, Polonia, Russia, Sudafrica e Ucraina) si astennero e due (Yemen e Honduras) non parteciparono al voto.
Dietro la Dichiarazione c'erano quasi due secoli di diritti conquistati (dalla Rivoluzione Francese in avanti) e, spesso, poco applicati. C'erano diversi documenti: dai Quattordici punti del presidente Usa Woodrow Wilson (1918) e le Quattro Libertà enunciate da Franklin Delano Roosevelt nella Carta Atlantica del 1941. C'era tanta filosofia che andava alle radici dell'uomo e sosteneva principi come l'uguaglianza, la personalità incoercibile e la necessità assoluta che la comunità umana si facesse carico dei diritti di tutti. Dove e quando questo non era accaduto, le conseguenze erano state guerre terribili e grandi carneficine con milioni di morti, fame, dolore, violenza e picchi incredibili di disumanità.
Probabilmente, anche chi redasse la Dichiarazione sapeva benissimo che certe cose non bastava scriverle, ma che ci sarebbero voluti decenni, forse secoli per fare passi avanti.
L'articolo 1 definisce il principio in base al quale è stata stilata la Dichiarazione: "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza". Nel secondo si afferma che i diritti in questione spettano a tutti gli uomini "senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione". .
Gli articoli dal 3 all'11 definiscono quali sono i diritti individuali. Ne fanno parte i diritti a "vita, libertà e sicurezza". Poi, una serie di diritti "negativi": no alla schiavitù, alla tortura, alle discriminazioni di ogni genere, agli arresti, alla detenzione ingiustificata e all'esilio. E ancora il diritto a essere giudicato in un tribunale indipendente e imparziale e a ricorrere contro discriminazioni e violazioni dei suoi diritti. Infine la presunzione di innocenza e il diritto a non essere giudicato per un comportamento o un atto che non sia stato considerato reato da una legge.
Dall'articolo 12 al 17 si stabiliscono i diritti del singolo nei confronti della comunità di cui fa parte. Sono diritti molto attuali perché comprendono (art 13) la libertà di movimento e, per così dire di "migrazione": "Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese". All'art. 14 c'è il diritto di asilo che il recente ddl Sicurezza approvato dal Parlamento italiano, ha messo pesantemente in discussione: "Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni" (salvo che una persona sia ricercata per altri reati).Seguono i diritti alla cittadinanza, a sposarsi e a farsi una famiglia senza limiti di religione e con il pieno consenso di entrambi gli sposi. Infine il diritto alla proprietà e a non esserne privato arbitrariamente.
Gli articoli dal 18 al 21 definiscono le libertà fondamentali di pensiero, parola, religione e partecipazione alla vita politica. Tutti gli uomini sono liberi di pensare, parlare e avere una religione che può essere manifestata in pubblico; liberi di avere un'opinione, di ricevere e dare informazione; liberi di riunirsi, di associarsi e di non essere obbligato ad associarsi; liberi di partecipare al governo del proprio Paese personalmente e attraverso il voto.
Gli articoli dal 22 al 27 stabiliscono i diritti economici e sociali. Si va dalla sicurezza sociale, al lavoro, parità di retribuzione a parità di lavoro (in tanti paesi anche avanzati, questo diritto non è garantito alle donne); diritto a una remunerazione equa e soddisfacente, ad aderire o a fondare un sindacato per difendere i propri diritti. Vengono poi definiti anche il diritto allo svago, all'alimentazione, alle cure mediche, alla sicurezza, all'istruzione, alla tutela della maternità e dell'infanzia a prendere parte alla vita culturale e sociale della comunità, di godere delle arti e di vedere tutelati i propri diritti sulle opere prodotte.
Gli ultimi tre articoli definiscono gli ambiti di applicazione della Dichiarazione. Viene definito l'ambito internazionale di applicazione dei diritti, i loro limiti e il fatto che non ci possono essere diritti e libertà che vadano contro le linee e i principi delle nazioni Unite. Infine, il fatto che nessuno Stato, gruppo e persone può agire per abbattere i diritti definiti nella dichiarazione.
Complessivamente, questa Dichiarazione universale, prende la forma e la sostanza di una sorta di Costituzione mondiale, o meglio, della parte introduttiva di una Carta internazionale che, come accade nelle Costituzioni definisce i diritti e i principi a cui un Paese intende ispirarsi. Come spesso accade in questo tipo di cose, le parole sono bellissime, importanti e tutte giuste. Ma l'applicazione, purtroppo, non è mai così facile e molti dei Paesi che l'hanno sottoscritte non hanno più molta voglia di metterle in pratica.
.
© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata